WE WERE SOLDIERS FINO ALL’ULTIMO UOMO
Ci sono stati il bello e atipico (anche se duro) Tigerland di Joel Schumacher (ambientato in un durissimo campo d’addestramento per le reclute destinate al Vietnam, capace di giocare con serietà con le convenzioni del genere) e lo strombazzato Black Hawk Down di Ridley Scott (molto più scontato nella sua “morale” anche se virtuosistico nella regia), e buona ultima arriva la seconda fatica alla regia di Randall Wallace, sceneggiatore del premio Oscar Braveheart e già regista de La maschera di ferro, oltre che sceneggiatore di Pearl Harbor (una pellicola che tuttavia considera meno sua, dal momento che regista e produttore hanno ampiamente modificato, e a sua detta impoverito, la storia che aveva scritto).
Randall Wallace
Randall Wallace
Valori Educativi
0Pubblico
Giudizio Artistico
0—
Cast & Crew
Regia
Randall Wallace
Sceneggiatura
Randall Wallace
Our Review
We were soldiers, tratto dal volume –in Italia pubblicato da Piemme- We were soldiers once… and young di Hal Moore e Joe Galloway (il primo colonnello protagonista anche del film, il secondo reporter di guerra che lo ha aiutato a raccogliere le testimonianze dei fatti raccontati), è stato da più parti accusato di essere un film non solo e non tanto mal riuscito, ma soprattutto “fuori luogo”, nutrito di una retorica ormai vecchia e inaccettabile, contributo ormai tardivo e poco aggiornato alla riflessione che la settima arte ha dedicato al decennale impegno yankee nel sud est asiatico. È curioso che sia stato avvertito come falso e stereotipato un film che racconta fedelmente la storia vera (forse nei titoli del film questo andava messo meglio in rilievo, soprattutto per il pubblico internazionale) di persone ancora oggi viventi, primo fra tutti il protagonista Moore, interpretato da Mel Gibson.
La pellicola, infatti, si confronta con la “sporca guerra”, il Vietnam, bestia nera della coscienza collettiva americana, letta talvolta dal cinema come epopea gloriosa e sfortunata (Berretti Verdi) e molto più spesso, a partire dalla metà degli anni ’70, come tragedia e sconfitta umana e sociale ancor più che militare (basti ricordare Il Cacciatore, Nato il 4 luglio e Platoon), ma il suo intento non è certo fatto per compiacere il gusto degli intellettuali pacifisti ad oltranza. Scopo dichiarato, infatti, è “rendere onore” ai soldati che combatterono il conflitto (ed in particolare la sua tragica battaglia inaugurale nella Valle della Morte) con coraggio e onore, in primo luogo i giovani americani guidati da ufficiali severi ma paterni come il colonnello Moore, ma anche i soldati norvietnamiti, capaci di mettere in scacco, con la loro guerriglia imprevedibile, prima i Francesi e poi gli Americani .
“La pace non è la virtù degli imbelli, ma quella dei soldati, perché possano combattere senza odio” . Questa frase di Emmanuel Mounier sembra adatta ad esprimere con acutezza e provocatoria profondità lo spirito che anima la ricostruzione tentata da Wallace con uno stile che, a prescindere dalla regia della battaglia centrale del film (fortemente debitrice allo spielberghiano Salvate il soldato Ryan), risulta più simile, non solo visivamente, a quello dei classici hollywoodiani, molto lontana dal montaggio nervoso e spiazzante di Scott o dallo stile quasi documentaristico di Schumacher.
Per nulla tradizionale è, invece, la grande attenzione che il regista dedica al versante “domestico” della vicenda; mentre mostra l’addestramento dei reparti destinati ad aprire le danze con avversari nuovi ed imprevedibili, infatti, si prende il tempo di raccontare anche la vita quotidiana di uomini che hanno scelto di “fare la guerra” per mestiere, cercando di farci sentire le loro ragioni, i loro dubbi, la sofferenza che provano allontanandosi (forse per sempre) dai propri cari. E il tentativo di quotidiana normalità delle loro mogli, abituate a spostarsi da una base all’altra come nomadi, ma così umanamente in difficoltà quando è il momento di dire addio al padre dei propri figli.
Così, mentre dobbiamo riconoscere che soprattutto in questa parte iniziale manca un autentico approfondimento su quelle che potevano essere le ragioni di un impegno americano nel Vietnam, è commovente e lodevole sentire come il protagonista del film (molto ben “vissuto” da Mel Gibson) cerca di conciliare non solo il suo essere soldato con il suo essere padre (è il contenuto della bella scena ambientata nella cappella tra il capitano Moore e uno dei suoi ufficiali che ha appena avuto una bambina, così come del dialogo tra Moore e la figlia minore che gli chiede che cosa sia la guerra), ma soprattutto con il suo essere credente. Moore è un cattolico padre di cinque figli, un uomo che prega il suo Dio, Dio di amore e di pace, perché lo sostenga nelle sue azioni e protegga i suoi uomini, e che non ha timore di chiedere la vittoria, perché chi combatte non può permettersi di essere politically correct, ma solo di rispettare il valore del nemico, e, sostenuto dalla convinzione di difendere valori più alti, sperare, in ogni caso, di sopraffarlo.
Per lo sceneggiatore e regista, peraltro, è altrettanto importante raccontare il dramma delle mogli che restano a casa ad attendere un esito su cui non possono influire; in particolare la moglie di Moore che, mentre il marito si impegna a prendersi cura dei suoi uomini fino all’ultimo (e in questo film la massima “non lasciare nessuno indietro” è certamente molto più vissuta e interiorizzata che non nel meccanico slogan del film di Scott), si fa carico della consegna degli anonimi telegrammi che annunciano la morte di ogni uomo, vivendo e rivivendo l’angoscia di un campanello che può significare l’annientamento di una famiglia.
Gli uomini di Moore, del resto, sono l’avanguardia delle migliaia di soldati che per più di un decennio combatterono una guerra probabilmente insensata, ma che non per questo possono essere liquidati come assassini senza perdono. Proprio il fatto di cogliere il momento iniziale di quegli eventi ormai parte della memoria di tutti, facendo seguire allo spettatore le vicende di individui che non portano già il marchio di consapevoli “invasori”, voleva essere probabilmente l’occasione per ritrovare un impossibile “sguardo vergine” su un tema ormai archiviato come impopolare dal giudizio della storia.
Quello che molti dimenticano e che forse sarebbe stato giusto richiamare in questo film è che l’anno dell’inizio della guerra in Vietnam cade a non molta distanza dalla crisi di Cuba, in anni in cui la minaccia dell’Unione Sovietica, e quindi anche del dilagare nel mondo di regimi di stampo comunista, erano fortemente sentiti non solo dagli Stati Uniti, ma da tutto il blocco occidentale. Forse tenendo presente questo aspetto risulta più comprensibile (anche se ancora tutta da valutare) la decisione dell’amministrazione e dell’esercito americani di coinvolgersi in una guerra che fin dall’inizio appariva difficile e presto anche impopolare.
Lungi dal voler diffondere una propaganda di bassa lega a favore del grande Impero americano, poi, è chiaro che gli autori del film (il regista-sceneggiatore in primo luogo ma anche i due scrittori del libro di memorie) intendevano più di tutto tributare il giusto onore a uomini valorosi e fondamentalmente retti (più ambigui i loro superiori, colpevoli nel mandarli allo sbaraglio senza garantire un adeguato supporto, ma ancora di più nel non fornire loro reali e profonde ragioni per combattere), mostrando tutto il dolore e l’orrore (soprattutto nello sguardo sconvolto del reporter, un personaggio che giunge forse un po’ troppo tardi per inserirsi bene nella storia e fare da riferimento per il pubblico) di cui nessuno degli uomini, a battaglia conclusa, è in grado di dire nulla, purtroppo solo un tragico anticipo di future e ben più ampie carneficine.
A ben vedere, infatti, quello che avrebbe dovuto colpire i critici più severi è ciò che il film sembra in realtà suggerire nel commosso finale, qualcosa di sorprendente e provocatorio, detto non a caso per bocca del comandante delle forze nord vietnamite sconfitte: la vittoria conquistata a caro prezzo, grazie al coraggio e alla genialità sfoderate contro un nemico altrettanto coraggioso e perspicace, convinse l’America a fare di quell’angolo di mondo un “affare americano” e si rivelò quindi, a conti fatti, una ben più grave sconfitta perché il risultato finale era già segnato, solo che per arrivarci sarebbe stato necessario pagare un tributo di sangue molto più alto.
Un film dunque che sarebbe troppo facile e ingiusto liquidare come guerrafondaio e retorico (anche se indubbiamente un supplemento di riflessione nelle direzioni indicate sopra avrebbe permesso una maggiore problematizzazione di alcune istanze); un film che ricostruisce figure di militari, ma soprattutto di uomini, chiamati a confrontarsi con un dovere non sempre facile e che solo in parte può diventare oggetto di discussione; uomini che trovano la forza di affrontare il pericolo e spesso la morte grazie alla fede, all’esempio di superiori (così simili a padri) e agli affetti, affetti che si trovano naturalmente e spontaneamente ad estendere alla famiglia dei compagni d’arme; ed è solo per questo, infatti, che ha senso allontanarsi dalla propria famiglia, tornare indietro per non lasciare un uomo a morire da solo, rischiare di farsi uccidere per portare in salvo qualche ferito in più, disubbidire agli ordini quando dicono di lasciare il campo per salvarsi abbandonando chi dipende da noi, trovare il tempo, in mezzo al fuoco del nemico, per pregare sui cadaveri dei caduti. Nessuna retorica di patria e di onore sarebbe capace di spingere a tanto.
E sono queste scelte concrete ed autentiche, molto più del discorso alle truppe (forse davvero un po’ retorico nel celebrare l’unità multietnica della grande nazione americana), a rimanere nel cuore di chi assiste ad una storia amara e tutt’altro che gloriosa, ma in molti momenti capace di toccare corde inedite e di trasmettere le profonde convinzioni di chi ha realizzato questo film.
Autore: Luisa Cotta Ramosino
Details of Movie
| Titolo Originale | WE WERE SOLDIERS |
|---|---|
| Paese | USA |
| Etichetta | Non classificato |


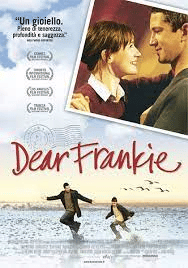






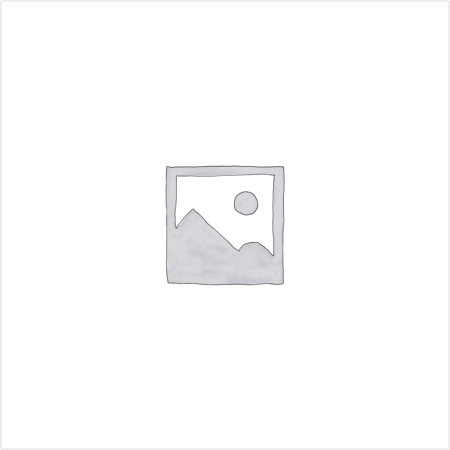

There are no reviews yet.