LA DOLCE VITA
Marcello è un giornalista romano in cerca di scoop per il suo rotocalco scaldalistico nel mondo dei frequentatori di Via Veneto. Non si lascia sfuggire l'arrivo di Sylvie, celebre attrice americana e la segue affascinato in una pazza notte trascorsa fra i locali notturni e i monumenti di Roma. Per dovere professionale Marcello si occupa di una falsa apparizione della Madonna, inventata da due bambini. Arriva invece la pioggia e tutti, operatori cinematografici e semplici curiosi, scappano via. Marcello conosce Steiner, un nobile intellettuale felicemente sposato con due figli; ne ha grande ammirazione e pensa di riprendere a scrivere quel libro che non ha mai terminato e di sposare finalmente la sua Emma. Il suicidio di Steiner getta Marcello nel più grande sconforto e riprende la vita mondana di sempre. Dopo un'orgia, Marcello esce all'aperto stordito dall'alcol: nota dall'altra parte della spiaggia una giovinetta che gli dice qualcosa ma lui non la capisce; la saluta e si unisce agli amici che stanno salendo in macchina per andar via.
Gray Film
pathè Cinema
Valori Educativi
Pubblico
18+Giudizio Artistico
-
Cast & Crew
Regia
Federico Fellini
Sceneggiatura
Federico Fellini
Tullio Pinelli
Brunello Rondi
Ennio Flaiano
Our Review
 In un’aggiornata e sintetica ricostruzione della storia del cinema italiano, Gian Piero Brunetta definisce giustamente La dolce vita di Federico Fellini un «grandioso affresco sociale e cinematografico […] un’opera ponte: chiude una stagione del cinema italiano e inaugura una nuova era, precorrendo non poche tensioni e spinte del cinema internazionale»[1]. A pochissimi anni di distanza, tornando nuovamente sull’opera di Fellini, e ritenendola il vero salto di qualità per il cinema italiano, Brunetta scrive che con La dolce vita il regista riminese «scopre e inventa una forma di epica cinematografica di cui, in seguito, apparirà come il cantore più imitato e difficilmente ripetibile. Da un momento all’altro egli si sente liberato dai complessi nei confronti del super ego della critica, per cui si lascia guidare dal proprio immaginario, armando tutte le vele, che per anni era stato costretto a orzare per la miopia dei produttori. La sua navigazione assume subito un andamento maestoso. Quello che è certo e subito palese alla critica è che il modello e l’idea di cinema, verso cui Fellini punta, sono situati in un emisfero posto agli antipodi del cinema neorealista, ancora considerato […] punto fondamentale di orientamento»[2].
In un’aggiornata e sintetica ricostruzione della storia del cinema italiano, Gian Piero Brunetta definisce giustamente La dolce vita di Federico Fellini un «grandioso affresco sociale e cinematografico […] un’opera ponte: chiude una stagione del cinema italiano e inaugura una nuova era, precorrendo non poche tensioni e spinte del cinema internazionale»[1]. A pochissimi anni di distanza, tornando nuovamente sull’opera di Fellini, e ritenendola il vero salto di qualità per il cinema italiano, Brunetta scrive che con La dolce vita il regista riminese «scopre e inventa una forma di epica cinematografica di cui, in seguito, apparirà come il cantore più imitato e difficilmente ripetibile. Da un momento all’altro egli si sente liberato dai complessi nei confronti del super ego della critica, per cui si lascia guidare dal proprio immaginario, armando tutte le vele, che per anni era stato costretto a orzare per la miopia dei produttori. La sua navigazione assume subito un andamento maestoso. Quello che è certo e subito palese alla critica è che il modello e l’idea di cinema, verso cui Fellini punta, sono situati in un emisfero posto agli antipodi del cinema neorealista, ancora considerato […] punto fondamentale di orientamento»[2].
Dai giudizi del maggior storico della cinematografia italiana, emergono due snodi determinanti. Il primo riguarda la produzione nazionale: dopo le grandi fortune dell’esperienza neorealista, soprattutto internazionali, ormai in via di esaurimento, con La dolce vita il cinema italiano raggiunge picchi di qualità eccezionali, nell’anno 1960, peraltro ricco di grandi film quali Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti, L’avventura di Michelangelo Antonioni e La ciociara di Vittorio De Sica. Il secondo snodo riguarda invece la collocazione del film di Fellini nel contesto internazionale, considerata un’opera faro della modernità cinematografica. Se tali giudizi Brunetta li inserisce all’interno di un grande, imponente lavoro di investigazione e sistematizzazione della storia del cinema italiano, il «fellinologo» per antonomasia, Tullio Kezich, di fatto da tutt’altra prospettiva, un saggio di ricordi, li conferma. «Il riminese – scrive – stava compiendo sul corpo del nostro cinema il miracolo della resurrezione»[3]. E La dolce vita finì, sempre a parere di Kezich, per dare forma ad «una fra le più tipiche espressioni del cinema moderno»[4].
Brunetta nelle sue analisi introduce il concetto di «opera mondo». Seguendo l’indicazione, possiamo paragonare il film di Fellini ad un’opera nella quale lo spirito del tempo rimane perfettamente condensato nella celluloide; spirito segnato da una profondissima nostalgia per il sacro, che sembra ormai abbandonare l’orizzonte umano, e una insopprimibile curiosità per gli aspetti più stravaganti della vita moderna. La nuova società cinematica, affermatasi pienamente con la fine della seconda guerra mondiale, contribuisce alla sostituzione del romanzo con il film di finzione. I consumi di massa e le logiche dell’industria culturale hanno determinato la moltiplicazione, in maniera sempre crescente, di «nuovi testi» (i film), talvolta considerati addirittura eccezionali, vere e proprie opere d’arte, assurte a preciso sistema estetico di rappresentazione sociale della embrionale cultura postmoderna[5]. Ma tra le opere d’arte, ve ne sono alcune rarissime: le chiameremo racconti epici o meglio, come già anticipato, «opere mondo». La dolce vita può essere considerata, appunto, «opera mondo».
Il film di Fellini è dunque un testo di riferimento della cultura cinematografica occidentale: racconto epico per immagini, dotato di una valenza culturale in grado di superare i confini nazionali. Pur se portatrice di uno Zeitgeist epocale, l’opera felliniana appare il nitido ritratto della società italiana in pieno boom economico, ripresa attraverso la finzione cinematografica, in una fase di forte consolidamento e quindi più libera nel potersi mettere in mostra.
 Come ha notato lo scrittore Antonio Tabucchi, il film «costituì una frattura generale». A Tabucchi La dolce vita appare un «grande affresco sull’Italia fra gli anni Cinquanta e Sessanta». Nel corso di una intervista Tabucchi ha provato a leggere il film di Fellini come una sorta di giudizio universale privo di salvezza. Ogni classe sociale è condannata, a cominciare dall’alta borghesia: «in fondo – dice Tabucchi – l’Italia non ha mai avuto una borghesia intelligente, colta… Poi c’è la piccola borghesia, il padre di Marcello che arriva a Roma dalla provincia e vuol fare la notte di follie al tabarin: un disastro. Un personaggio toccante, patetico. E patetica è anche Yvonne Furneaux, la “moglie italiana” con le sue fissazioni, possessiva e disperata per quel voler accudire Marcello, preparargli i ravioli con la ricotta. Ecco poi i nobili, l’aristocrazia romana che si raduna per la festa nel castello di Sutri: una galleria di inetti o di puri deficienti. Ma c’è anche il popolino, il sottoproletariato, quello che spera nelle apparizioni della Madonna e si presta alle riprese della Tv. Il cerchio si chiude con gli intellettuali; c’è Marcello Rubini (Mastroianni), il giornalista che vuol diventare grande scrittore e intanto lavora per una rivista scandalistica: crede di avere importanti aspirazioni, e invece è solo patetico. Più in alto, molto più in alto c’è Steiner (Alain Cuny), una mente raffinata, nutrita di cultura filosofica e di letture scelte, suona Bach. Ha un salotto frequentato da scrittori e artisti, a cui fa ascoltare la registrazione dei suoni della natura. Ma ha anche una famiglia, due bimbi, la moglie sorridente: insomma, sembra un esempio perfetto di equilibrio e serenità. E invece è un fallito, e il suo suicidio cambia radicalmente il giudizio su tutto: quelle riunioni di intellettuali che parevano tanto scelti, tanto profondi, erano solo poveri ricevimenti di persone vuote e fatue.
Come ha notato lo scrittore Antonio Tabucchi, il film «costituì una frattura generale». A Tabucchi La dolce vita appare un «grande affresco sull’Italia fra gli anni Cinquanta e Sessanta». Nel corso di una intervista Tabucchi ha provato a leggere il film di Fellini come una sorta di giudizio universale privo di salvezza. Ogni classe sociale è condannata, a cominciare dall’alta borghesia: «in fondo – dice Tabucchi – l’Italia non ha mai avuto una borghesia intelligente, colta… Poi c’è la piccola borghesia, il padre di Marcello che arriva a Roma dalla provincia e vuol fare la notte di follie al tabarin: un disastro. Un personaggio toccante, patetico. E patetica è anche Yvonne Furneaux, la “moglie italiana” con le sue fissazioni, possessiva e disperata per quel voler accudire Marcello, preparargli i ravioli con la ricotta. Ecco poi i nobili, l’aristocrazia romana che si raduna per la festa nel castello di Sutri: una galleria di inetti o di puri deficienti. Ma c’è anche il popolino, il sottoproletariato, quello che spera nelle apparizioni della Madonna e si presta alle riprese della Tv. Il cerchio si chiude con gli intellettuali; c’è Marcello Rubini (Mastroianni), il giornalista che vuol diventare grande scrittore e intanto lavora per una rivista scandalistica: crede di avere importanti aspirazioni, e invece è solo patetico. Più in alto, molto più in alto c’è Steiner (Alain Cuny), una mente raffinata, nutrita di cultura filosofica e di letture scelte, suona Bach. Ha un salotto frequentato da scrittori e artisti, a cui fa ascoltare la registrazione dei suoni della natura. Ma ha anche una famiglia, due bimbi, la moglie sorridente: insomma, sembra un esempio perfetto di equilibrio e serenità. E invece è un fallito, e il suo suicidio cambia radicalmente il giudizio su tutto: quelle riunioni di intellettuali che parevano tanto scelti, tanto profondi, erano solo poveri ricevimenti di persone vuote e fatue.
Insomma, La dolce vita è il ritratto più terribile che un artista abbia prodotto sulla società italiana. Profeticamente, Fellini aveva già intuito dove saremmo andati a parare. Il modo con cui rappresenta i mezzi di comunicazione di massa è rivelatore. I fotografi scatenati e urlanti dietro le celebrità, i giornalisti che s’inventano stupidi scoop (Anita Ekberg vestita da prete che sale sulla cupola di San Pietro), gli scatti rubati della diva presa a schiaffi dal suo compagno, la spettacolarizzazione del niente. E la Tv? Anche peggio: la sequenza del finto miracolo sui pratacci dell’ultima periferia romana è atroce. Due bambini che dicono di aver visto la Madonna attirano la troupe della Rai, che vuole dare di tutto, di più. In mezzo a una falsa agitazione, tutti recitano: i piccoli veggenti, la folla pronta ad andare in estasi, lo zio orrendo dei ragazzini che intona le laudi, lo speaker della Tv. Poi, comincia a scendere la pioggia, di Madonne nemmeno l’ombra, e l’operatore cinicamente esclama: “Piove! Spegniamo tutto”. Un’Italia orrenda degli inizi degli anni Sessanta, Paese corrotto e decadente, terra in cui niente si salva né può essere salvato, società putrefatta come la Roma del Satyricon di Petronio […] Ci sono tutti i difetti italiani, quel viver bene alla giornata, il cinismo generale che accomuna sottoproletari, intellettuali, borghesi. Il velleitarismo del giornalista Marcello è desolante: il suo dialogo con Anita Ekberg, nella scena della fontana, è agghiacciante. “Sì, è vero, ho sbagliato tutto, hai ragione tu…” e va nell’acqua dietro alla bionda formosa e cretina che s’inebria nel primordiale, nell’arte, nella romanità di quel tuffo barocco di Trevi. E altrettanto tremendo è l’episodio del miracolo della Madonna. Speriamo tutti, anch’io, di vedere la Madonna, ma la Madonna di quelle borgate non ci promette la vita eterna, tutt’al più una vacanza a Fregene. Si lascia comprare con quattro soldi, costa due lire, non era l’apparizione felice, immortale, era una povera cosa di cartone»[6].
La lunga citazione è utile per evidenziare una mentalità diffusa, ben espressa da Tabucchi, impegnata ad affastellare troppe riflessioni, con la lettura del presente sovrapposta al passato, nella quale si fondono vizi e disfunzioni non tanto legate al tempo del film di Fellini, ma quanto riconducibili alla contemporaneità. Inoltre la severa reprimenda di Tabucchi getta una luce poco edificante sull’Italia uscita da un decennio di straordinaria evoluzione sociale e di solida guida politica (il centrismo democristiano di Alcide De Gasperi, rimasto al governo sino al 1953). Un giudizio del genere non può essere circoscritto al fraintendimento di un letterato incapace di cogliere l’essenza della dinamiche storiche. Tabucchi si trova in perfetta sintonia con le analisi espresse da una diffusa pubblicistica e da una predominate storiografia, impegnate a distorcere il reale significato della stagione degasperiana. Il potente sviluppo economico prodotto dalla modernizzazione industriale e dalla società dei consumi, non è contrassegnato, a parere di Tabucchi, da un’eguale crescita morale, culturale e civile dello spirito nazionale: osservazioni molto discutibili. Lo storico Pietro Scoppola ha sottolineato come l’interpretazione degli anni Cinquanta, nella cultura italiana, ha l’immagine «di un certo grigiore». Questa lettura dominante «diventa in alcune delle ancora approssimative ricostruzioni di quel periodo un preciso giudizio: alla fine degli anni quaranta si sarebbe aperta, nella vita politica e nella cultura, una fase di restaurazione nel senso deteriore del termine»[7]. Come è sin troppo evidente, il pensiero di Tabucchi si distacca davvero poco da questa linea interpretativa.
 Ciò non toglie però che i rilievi dello scrittore affrontino un punto fondamentale: la città di Roma è ormai diventata, e La dolce vita ne è la massima rappresentazione, un luogo geografico totale, dove sta andando in scena l’apoteosi della modernità. Roma trattiene i segni del passaggio compiuto (la conclusione della modernità) e al tempo stesso presenta la fisionomia embrionale di un cominciamento(il superamento della modernità). La città eterna si è trasformata, grazie al potere seducente della celluloide, nella «Hollywood sul Tevere»[8], divenendo il centro del mondo, come lo sono Parigi nei film della «nouvelle vague» e la «Swinging London» di Blow-up (1966) di Michelangelo Antonioni, o la Madrid al tempo della «movida», in alcune opere dei primi anni Ottanta di Pedro Almódovar. «La dolce vita – scrive opportunamente Vito Zagarrio – passa alla Storia come la più famosa celebrazione dei fasti della modernizzazione (la “movida” romana, via Veneto, i veicoli di comunicazione di massa), e insieme l’innesto di elementi di rinnovamento linguistico e narrativo […] Ma la stessa atmosfera de La dolce vita, a ben vedere, è insieme “moderna” e “postmoderna”, soprattutto per il mescolamento di arredi e di scenografie, di musiche e di culture (l’oriente e l’occidente, il rock ’n’ roll e l’impero romano, l’aereo e l’elmo medievale, ecc.)»[9].
Ciò non toglie però che i rilievi dello scrittore affrontino un punto fondamentale: la città di Roma è ormai diventata, e La dolce vita ne è la massima rappresentazione, un luogo geografico totale, dove sta andando in scena l’apoteosi della modernità. Roma trattiene i segni del passaggio compiuto (la conclusione della modernità) e al tempo stesso presenta la fisionomia embrionale di un cominciamento(il superamento della modernità). La città eterna si è trasformata, grazie al potere seducente della celluloide, nella «Hollywood sul Tevere»[8], divenendo il centro del mondo, come lo sono Parigi nei film della «nouvelle vague» e la «Swinging London» di Blow-up (1966) di Michelangelo Antonioni, o la Madrid al tempo della «movida», in alcune opere dei primi anni Ottanta di Pedro Almódovar. «La dolce vita – scrive opportunamente Vito Zagarrio – passa alla Storia come la più famosa celebrazione dei fasti della modernizzazione (la “movida” romana, via Veneto, i veicoli di comunicazione di massa), e insieme l’innesto di elementi di rinnovamento linguistico e narrativo […] Ma la stessa atmosfera de La dolce vita, a ben vedere, è insieme “moderna” e “postmoderna”, soprattutto per il mescolamento di arredi e di scenografie, di musiche e di culture (l’oriente e l’occidente, il rock ’n’ roll e l’impero romano, l’aereo e l’elmo medievale, ecc.)»[9].
L’opera di Federico Fellini compie più o meno lo stesso percorso. Dopo i primi passi nell’orizzonte della commedia, sempre più sicuri, con Luci del varietà (1950, diretto in collaborazione con Alberto Lattuada), Lo sceicco bianco (1952) e I vitelloni (1953), Fellini si avventura nell’universo proprio del realismo, realizzando opere di grande importanza stilistica quali La strada (1954) e Le notti di Cabiria (1957), che assicurano al regista riminese successo e notorietà internazionali. Fellini, formatosi a stretto contatto con il regista di punta del neorealismo, Roberto Rossellini, si avvicina al realismo con i tratti propri dell’umanesimo cristiano[10]. Rossellini nei film girati con Ingrid Bergman come protagonista, si impegna nella rifondazione del realismo (e del neorealismo), salutata dalla giovane critica francese con enorme favore[11], e da altri frontalmente osteggiata con l’accusa di «spiritualismo»[12]. Quindi se nel Rossellini diStromboli, terra di Dio (1949), Europa ’51 (1952) eViaggio in Italia (1953), per ragioni estetiche e morali (centrate sul realismo della messa in scena e sull’umanesimo cristiano del contenuto), debba essere rintracciata la vera origine della modernità, in Fellini troviamo la medesima sensibilità e un puntuale e originale prolungamento. Con la «trilogia della grazia e della salvezza», a parere di Peter Bondanella, il regista riminese si avvicina all’umanesimo cristiano. Pertanto, assai prima dell’anno-cerniera 1959 (ricordiamolo: l’anno dell’esplosione della «nuovelle vague» in Francia e delle opere faro della modernità), Fellini concorre con la sua ricerca estetica e valoriale, espressa ai massimi livelli in La strada e Le notti di Cabiria, alla formazione della modernità cinematografica, che si preciserà ulteriormente con La dolce vita e con il successivo 8 e ½ (1963). La modernità del cinema non è soltanto una questione legata alla tecnica impiegata, o al grado di realismo dell’opera, ma anche, e forse soprattutto, una rinnovata visione del mondo, operata attraverso il linguaggio filmico, da un gruppo di cineasti, nella stragrande maggioranza europei, di cui Rossellini e Fellini sono stati certamente i precursori.
Per René Predal Fellini appartiene a questo sguardo nuovo sul mondo, e La dolce vita si presenta «come un labirintico monumento barocco della decadenza, in cui il realismo devia costantemente verso il fantastico […] Mescolando le apocalissi derisorie (il diluvio sui figli del falso miracolo) agli interrogativi più tremendi (l’episodio di Steiner che assassina la famiglia) e le notti folli (il bagno di Anita Ekberg nella fontana di Trevi o la frenesia di via Veneto) alle albe glaciali (i tentativi di suicidio di Emma o il malessere del vecchio padre), La dolce vita stila il miserevole bilancio di un mondo ammalato con un delirio estetico che lo fa tuttavia scintillare di mille bagliori»[13]. È uno dei tanti giudizi, né il migliore né il peggiore, riguardanti il film di Fellini. Non è questa la sede per discutere dettagliatamente il significato formale e contenutistico di La dolce vita. È sufficiente ribadire che del grande rinnovamento artistico verificatosi sul finire degli anni Cinquanta del XX secolo, e durato per tutto il decennio successivo, entrato nella storiografia come la modernità del cinema, Fellini e il suo film rappresentano un passaggio imprescindibile.
Abbiamo in precedenza sottolineato la presenza in La dolce vita di un duplice atteggiamento di Fellini: la nostalgia per l’eclissarsi del sacro nella «città secolare» – fenomeno storico ritenuto inarrestabile – e la curiosità per gli aspetti più stravaganti del moderno. Studiando strutturalmente il film emerge la suddivisione in scene non necessariamente concatenate una all’altra, che in alcuni casi potrebbero addirittura vivere autonomamente, per durata e significato. Il film di Fellini è una descrizione dei demoni che si sono impossessati dell’uomo quando perde il contatto con Dio.
Fellini osserva con immensa curiosità il moderno. Lo sguardo plana dall’alto sull’eclissi del sacro scesa nella moderna Babilonia di Roma – ricordiamolo ancora: il centro del mondo – e fa affiorare in superficie la «volontà di potenza» impossessatasi dell’esistenza del protagonista di La dolce vita, Marcello Rubini.
Le sequenze del film
 Il film, di una lunghezza consistente e anomala per il cinema italiano (due ore e quarantacinque minuti), è diviso in tredici scene, legate da una sola linea di continuità: la presenza di Marcello. Marcello (Marcello Mastroianni) è un giornalista trasferitosi a Roma per seguire l’arte della scrittura. Presto però ha abbandonato ogni velleità letteraria, tuffandosi nella «dolce vita» romana, tra un aperitivo a via Veneto e una serata trascorsa con la nobiltà, a caccia di pettegolezzi, informazioni e storie piccanti, da passare alla stampa in perenne ricerca di scandali. Così Tullio Kezich disegna il profilo di Marcello: «è un giornalista mondano che capta gli scandali e gli umori della café-society. Un tipo né buono né cattivo, né morale né amorale, con improvvisi spunti di cinismo e altrettanto improvvisi soprassalti»[14]. La dolce vita, come è noto, si apre con l’immagine di un elicottero impegnato a trasportare una grande statua di «Gesù Lavoratore», dono degli operai alla «città eterna». In realtà gli elicotteri sono due: nel secondo c’è Marcello con Paparazzo (Walter Santesso), il fotografo inseparabile accompagnatore. Nel tempo messo in scena da Fellini, temporalità contrassegnato dal «presente», propria a tutte le grandi opere cinematografiche della modernità[15], l’obiettivo della macchina da presa è puntato su una questione determinante: la fede sta tagliando uno ad uno gli ormeggi con la società. Detta in altre parole, stiamo assistendo all’eclissi del sacro, come una corrente di pensiero sostiene, nell’ambito della sociologia delle religioni[16]; o alla secolarizzazione, disciplina della teologia impegnata a definire il processo storico mediante il quale la cultura e la società occidentale si affrancano dal controllo religioso. Non c’è immagine più suggestiva del Cristo volteggiante nel cielo, seguito da un uomo immerso nel proprio tempo, privo di legami religiosi, per riassumere la fisionomia di un’epoca appunto secolare. La breve sequenza di apertura del film di Fellini è seguita da un’immagine assai diversa. Siamo entrati nel vortice della «città secolare», in un locale notturno nel centro del centro del mondo; non la Roma di San Pietro, ma la Roma di via Veneto. Marcello si trova lì a caccia di notizie, e incontra Maddalena (Anouk Aimée), figlia annoiata di un facoltoso industriale. I due escono in strada, salgono su una lussuosa automobile americana decappottabile, caricano una prostituta e si fanno portare a casa sua, nella desolata periferia della città. All’alba escono, pagano la donna, e vanno via. Siamo così arrivati alla terza scena, anch’essa piuttosto breve. Marcello rincasa e scopre che la fidanzata Emma (Yvonne Fourneaux) ha tentato di suicidarsi per gelosia. Prontamente ricoverata in ospedale, la donna viene dichiarata fuori pericolo di vita.
Il film, di una lunghezza consistente e anomala per il cinema italiano (due ore e quarantacinque minuti), è diviso in tredici scene, legate da una sola linea di continuità: la presenza di Marcello. Marcello (Marcello Mastroianni) è un giornalista trasferitosi a Roma per seguire l’arte della scrittura. Presto però ha abbandonato ogni velleità letteraria, tuffandosi nella «dolce vita» romana, tra un aperitivo a via Veneto e una serata trascorsa con la nobiltà, a caccia di pettegolezzi, informazioni e storie piccanti, da passare alla stampa in perenne ricerca di scandali. Così Tullio Kezich disegna il profilo di Marcello: «è un giornalista mondano che capta gli scandali e gli umori della café-society. Un tipo né buono né cattivo, né morale né amorale, con improvvisi spunti di cinismo e altrettanto improvvisi soprassalti»[14]. La dolce vita, come è noto, si apre con l’immagine di un elicottero impegnato a trasportare una grande statua di «Gesù Lavoratore», dono degli operai alla «città eterna». In realtà gli elicotteri sono due: nel secondo c’è Marcello con Paparazzo (Walter Santesso), il fotografo inseparabile accompagnatore. Nel tempo messo in scena da Fellini, temporalità contrassegnato dal «presente», propria a tutte le grandi opere cinematografiche della modernità[15], l’obiettivo della macchina da presa è puntato su una questione determinante: la fede sta tagliando uno ad uno gli ormeggi con la società. Detta in altre parole, stiamo assistendo all’eclissi del sacro, come una corrente di pensiero sostiene, nell’ambito della sociologia delle religioni[16]; o alla secolarizzazione, disciplina della teologia impegnata a definire il processo storico mediante il quale la cultura e la società occidentale si affrancano dal controllo religioso. Non c’è immagine più suggestiva del Cristo volteggiante nel cielo, seguito da un uomo immerso nel proprio tempo, privo di legami religiosi, per riassumere la fisionomia di un’epoca appunto secolare. La breve sequenza di apertura del film di Fellini è seguita da un’immagine assai diversa. Siamo entrati nel vortice della «città secolare», in un locale notturno nel centro del centro del mondo; non la Roma di San Pietro, ma la Roma di via Veneto. Marcello si trova lì a caccia di notizie, e incontra Maddalena (Anouk Aimée), figlia annoiata di un facoltoso industriale. I due escono in strada, salgono su una lussuosa automobile americana decappottabile, caricano una prostituta e si fanno portare a casa sua, nella desolata periferia della città. All’alba escono, pagano la donna, e vanno via. Siamo così arrivati alla terza scena, anch’essa piuttosto breve. Marcello rincasa e scopre che la fidanzata Emma (Yvonne Fourneaux) ha tentato di suicidarsi per gelosia. Prontamente ricoverata in ospedale, la donna viene dichiarata fuori pericolo di vita.
La quarta scena potrebbe considerasi un film a sé. Qui Fellini elabora una sofisticata ricostruzione dell’attraente modernità propria della società dei consumi, del divertimento e dell’industria culturale. Marcello deve recarsi all’aeroporto per accogliere una diva del cinema, Sylvia (Anita Eckberg), in arrivo a Roma. Sono trascorsi esattamente venti minuti dall’inizio del film, e allo spettatore è stato presentato Marcello, il protagonista; Maddalena, la sua amante, donna ricca, aristocratica e disinibita; ed Emma, fidanzata di Marcello, certo bella ma appartenente ad un ceto sociale basso. Ecco arrivare Sylvia, bellezza nordica, sensuale e prorompente. Questa parte del film dura trenta minuti ed è suddivisa in otto blocchi:
1 – arrivo di Sylvia all’aeroporto: una folla di giornalisti, fotografi, produttori, industriali e semplici curiosi accoglie la diva del cinema americano sbarcata a Roma per partecipare alla presentazione di un film
2 – Marcello, che lavora per la produzione del film, accompagna l’attrice in macchina dall’aeroporto al centro della città
 3 – nel corso della conferenza stampa Sylvia risponde in inglese a tutte le domande, seduta su un divano, le mani perennemente tra i lunghi capelli, con aria divertita, ingenua e maliziosa
3 – nel corso della conferenza stampa Sylvia risponde in inglese a tutte le domande, seduta su un divano, le mani perennemente tra i lunghi capelli, con aria divertita, ingenua e maliziosa
4 – Marcello, insieme ad un fotografo, accompagna Sylvia, fasciata in uno strano vestito dai richiami ecclesiastici, in Vaticano: prima salgono una ripida scala e, raggiunta la cima, si trovano in una terrazza con vista su Piazza San Pietro
5 – in onore di Sylvia e del suo fidanzato Robert (Lex Barker, famoso per aver interpretato Tarzan sullo schermo), il produttore Totò Scalise (Carlo Di Maggio) ha organizzato una serata mondana, in abiti da antichiromani: Robert ha alzato parecchio il gomito; rimprovera Sylvia di aver ballato con troppa disinvoltura, facendo infuriare la donna, che presa da un attacco d’ira abbandona la festa, inseguita da Marcello preoccupato di un possibile scandalo
6 – salita sulla macchina guidata da Marcello, Sylvia raggiunge il centro di Roma: è affascinata dalla bellezza notturna e gioca con un gattino bianco, perdendosi nelle tante stradine
7 – Marcello è riuscito a trovare un po’ di latte per il gattino, ma quando torna non trova più Sylvia, che nel frattempo è rimasta incantata dalla cascata di acqua della Fontana di Trevi: i due si bagnano, camminano abbracciati e l’alba li sorprende
8 – Marcello accompagna Sylvia in albergo in via Veneto: in una macchina c’è Robert addormentato, malignamente svegliato dai fotografi; l’uomo prima affronta Sylvia, schiaffeggiandola, e poi colpisce Marcello, sbattendolo in terra tra gli scatti divertiti dei colleghi.
Alcune immagini – soprattutto la scena del bagno nella Fontana di Trevi – ancora oggi rimangono un’icona di riferimento dell’immaginario collettivo internazionale. Ogni grande cultura nazionale nell’atto di prendere coscienza di se stessa, produce un autore enciclopedico ed un testo di riferimento: nel nostro caso abbiamo Federico Fellini e La dolce vita. D’abitudine i film vengono interpretati mediante una lettura della forma o del significato sociale.
 L’eroe è uno spettatore, elemento assai presente nelle opere della modernità del cinema. L’eroe è inerte, passivo: non dominatore ma esploratore. Non è il costruttore del mondo tipico del cinema classico hollywoodiano, come ad esempio John Wayne nel western di John Ford L’uomo che uccise Liberty Valance (The Man who Shot Liberty Valance, 1962). Marcello è una sorta di moderna incarnazione del Faust di Goethe: attraverso il patto mefistofelico decide di vendere l’anima non tanto alle forze del male, ma alla propria epoca secolarizzata, ricevendo in cambio il grimaldello per far saltare tutte le serrature delle regole sociali, e soprattutto il biglietto di ingresso alla giostra del lusso e del divertimento. È anche uno speculatore economico, poiché vive al centro della mondanità pur non avendone i mezzi. Marcello, ultima incarnazione di Faust, è stato sedotto dal fascino della vita scintillante, stordente, sfrenata. Il compromesso lo ha trascinato nell’universo della «dolce vita», e il prezzo da pagare è la perdita di eticità. Essendo in fondo vittima di una seduzione, Marcello agli occhi del suo creatore finisce per apparire innocente, scagionato da ogni responsabilità: non è un eroe sgradevole, e sicuramente qualcosa di superiore ha avuto la meglio su di lui, allontanandolo dalla ricerca artistica, dalla corretta condotta morale, dall’orizzonte del senso religioso. Marcello non viene punito per aver sprecato vita e talento, come accade, pescando un altro esempio dal classicismo hollywoodiano, all’eroe di Viale del tramonto (Sunset Boulevard, 1950) di Billy Wylder, opera dalla struttura classica ma fortemente intrisa di tendenze moderne. La particolarità di La dolce vita è di essere un testo dalla doppia polarità: innovatore ma popolare, complesso ma semplice, stilisticamente ricercato ma adatto al consumo tipico della cultura di massa. La dolce vita (peculiarità delle «opere mondo») è la manifestazione radicale del desiderio di emancipazione dell’uomo, l’affermazione della sua «volontà di potenza», impegnato a tagliare i legami con il passato; ma è anche la consapevolezza che non è possibile ricominciare totalmente da capo: anzi, è inutile .
L’eroe è uno spettatore, elemento assai presente nelle opere della modernità del cinema. L’eroe è inerte, passivo: non dominatore ma esploratore. Non è il costruttore del mondo tipico del cinema classico hollywoodiano, come ad esempio John Wayne nel western di John Ford L’uomo che uccise Liberty Valance (The Man who Shot Liberty Valance, 1962). Marcello è una sorta di moderna incarnazione del Faust di Goethe: attraverso il patto mefistofelico decide di vendere l’anima non tanto alle forze del male, ma alla propria epoca secolarizzata, ricevendo in cambio il grimaldello per far saltare tutte le serrature delle regole sociali, e soprattutto il biglietto di ingresso alla giostra del lusso e del divertimento. È anche uno speculatore economico, poiché vive al centro della mondanità pur non avendone i mezzi. Marcello, ultima incarnazione di Faust, è stato sedotto dal fascino della vita scintillante, stordente, sfrenata. Il compromesso lo ha trascinato nell’universo della «dolce vita», e il prezzo da pagare è la perdita di eticità. Essendo in fondo vittima di una seduzione, Marcello agli occhi del suo creatore finisce per apparire innocente, scagionato da ogni responsabilità: non è un eroe sgradevole, e sicuramente qualcosa di superiore ha avuto la meglio su di lui, allontanandolo dalla ricerca artistica, dalla corretta condotta morale, dall’orizzonte del senso religioso. Marcello non viene punito per aver sprecato vita e talento, come accade, pescando un altro esempio dal classicismo hollywoodiano, all’eroe di Viale del tramonto (Sunset Boulevard, 1950) di Billy Wylder, opera dalla struttura classica ma fortemente intrisa di tendenze moderne. La particolarità di La dolce vita è di essere un testo dalla doppia polarità: innovatore ma popolare, complesso ma semplice, stilisticamente ricercato ma adatto al consumo tipico della cultura di massa. La dolce vita (peculiarità delle «opere mondo») è la manifestazione radicale del desiderio di emancipazione dell’uomo, l’affermazione della sua «volontà di potenza», impegnato a tagliare i legami con il passato; ma è anche la consapevolezza che non è possibile ricominciare totalmente da capo: anzi, è inutile .
Nelle intenzioni di Fellini il film non ha nessuna pretesa di denunciare o di perorare qualsiasi causa. «Mette il termometro – dice il regista – ad un mondo malato, che evidentemente ha la febbre. Ma se il mercurio segna quaranta gradi all’inizio del film ne segna quaranta anche alla fine»[17]. Fellini ha nostalgia per il sacro (l’eclissi dei valori è un passaggio epocale non rasserenante), pur se ha deciso di misurarsi senza timore con il moderno.
Tornando alla struttura del racconto filmico, conclusa la lunga parentesi del passaggio romano di Sylvia, il film prosegue con la quinta scena, costruita per far incontrare casualmente Marcello con Steiner (Alain Cuny). Marcello sta seguendo annoiato il servizio di una modella ripresa accanto ad un cavallo. Ad un tratto sembra richiamato da qualcosa, e si reca nella moderna chiesa dalla grande entrata. Dentro la chiesa trova un amico: Steiner, uomo sofisticato, intellettuale raffinato e sensibile. Da parecchio tempo i due non si vedono. Iniziano a parlare di libri, di un articolo scritto da Marcello, piaciuto molto a Steiner. Poi quest’ultimo chiede ad un religioso il permesso di suonare il maestoso organo a canne della chiesa: esegue una musica sacra di Bach. Marcello ascolta, appare turbato: è affascinato da Steiner, figura che sembra intagliata nel legno, e ispira calma, serenità e regalità. L’attore, ricorda Kezich, richiama il gotico e ha un sapore di protestantesimo: «di spalle, con il colletto alto e bianco, fa pensare a un pastore»[18]. Durante la conversazione, Steiner chiede a Marcello perché abbia rinunciato a scrivere il romanzo. Nella scena successiva (la sesta), Marcello è stato inviato per un servizio giornalistico sulle apparizioni che si stanno verificando a quasi cinquanta chilometri da Roma. Lì, in un prato, la Madonna appare a due bambini del luogo. La sequenza, abbastanza lunga (dodici minuti), è strutturata in sei blocchi:
1 – Marcello in macchina con Emma, molto religiosa, e il fotografo Paparazzo, si recano da Roma al luogo delle apparizioni
2 – arrivo, di giorno, al «prato dei miracoli»: i bambini sono tenuti in custodia dalla polizia; sul posto ci sono curiosi, fotografi, reporter; la televisione ha montato un vero e proprio spettacolo; c’è chi veramente si aspetta la grazia dalla Madonna, chi invece ci specula e chi sta lì solo per non perdersi l’evento
3 – una dissolvenza ci fa vedere che è quasi sera, e che molta gente sta arrivando
4 – un’altra dissolvenza ci mostra che è notte e tutto è pronto per lo «spettacolo»
5 – finalmente arrivano i bambini, un maschio e una femmina, si inginocchiano davanti ad un alberello, mentre un cordone di poliziotti a stento riesce a stento a tenere lontani i presenti (alcune inquadrature dall’alto ci mostrano l’ambiente, dai tratti tipici di un circo all’aperto): inizia a piovere (ci sono vari malati portati sul posto in barella) e la pioggia presto si trasforma in diluvi, e sotto l’acqua scrosciante i bambini iniziano a correre in varie direzioni, dicendo di vedere la Madonna, e scatenando il pandemonio (la scena si conclude con una comunicazione dello zio dei bambini: la Madonna ha richiesto la costruzione sul prato di una chiesa, altrimenti non verrà più: l’alberello è preso d’assalto dalla folla, e anche Emma partecipa alla «sacra spoliazione», per poi accapigliarsi con un fotografo; intanto, nella confusione generale, un vecchio malato è morto)
6 – è l’alba, un prete inginocchiato davanti alla salma, coperta da un lenzuolo bianco, benedice il defunto: Emma poggia la testa sulla spalla di Marcello, mentre i fotografi continuano a scattare.
La settima scena, più o meno della durata della precedente (quattordici minuti), racconta la visita di Marcello a casa di Steiner, accompagnato da Emma, un po’ spaesata in quell’ambiente. Steiner li riceve con grandi convenevoli, nella bellissima abitazione dall’ampio soggiorno accogliente e luminoso, con un Morandi appeso alla parete. In casa Steiner è presente una sorta di aristocrazia della cultura internazionale, composta da filosofi, poetesse, scrittori, viaggiatori. Fellini considera Steiner «imponente e strano come una cattedrale gotica». Marcello vede nell’immagine severa dell’intellettuale ciò che vorrebbe essere ed avere: un lavoro appagante e intellettualmente stimolante, una splendida casa, tanti amici interessanti, una bella moglie e due bellissimi bambini. Marcello confessa a Steiner: «dovrei cambiare tante cose, avere delle ambizioni, ma forse sto perdendo tutto». Nella serata trascorsa a casa di Steiner, a Marcello sono state chieste informazioni sullo stato del romanzo. L’incontro ha fatto tornare a Marcello la voglia di scrivere: eccolo dunque, nell’ottava scena, brevissima (tre minuti), al mare, in una bella giornata di sole. Sta seduto davanti alla macchina da scrivere portatile, in un ristorante, all’ombra di una tettoia. Scambia alcune parole con una ragazzina, Paola (Valeria Ciangottini), cameriera al ristorante venuta dall’Umbria, della quale sente forte nostalgia: il suo profilo ricorda a Marcello il volto di un angelo.
Nella nona scena, molto lunga (ventitré minuti), Marcello è di nuovo a via Veneto. Al bar sotto la sede del giornale lo sta aspettando il padre (Annibale Ninchi). Il genitore è venuto a Roma per motivi di lavoro, e vuole incontrare il figlio. Da tempo i due non si vedono. Il padre è sbalordito e affascinato dal movimento di gente, nonostante l’ora tarda. Chiede a Marcello di andare in un locale notturno. Marcello lo accompagna volentieri. Al locale, decisamente fuori moda, si intrattengono con due ragazze, e una di loro, Fanny (Magali Noël), invita il padre a casa sua. Marcello, volutamente attardatosi, è rimasto in strada. Vede uscire Fanny di corsa: il padre si è sentito male e ha bisogno di una medicina. Marcello sale di corsa le scale: il padre si è ripreso, ed è intenzionato a ripartire. Sono le quattro del mattino e ha il treno alle cinque e mezza. Marcello insiste, quasi implora il genitore di fermarsi ancora un giorno. Ma l’uomo non sente ragioni: vuole tornare a casa. Fanny guarda dalla finestra i due salutarsi, e Marcello rimanere solo nella strada deserta, allo spuntare delle prime luci dell’alba.
Le decima scena, della durata di circa venti minuti, torna nuovamente in via Veneto. Marcello vi incontra una ragazza straniera, bionda e molto bella, Nicoletta (Nico Otzak: passerà alla storia non come attrice, ma come musa del pittore Andy Warhol e soprattutto cantante, col nome di Nico, voce del complesso Velvet Underground). La ragazza lo invita ad una festa di nobili in un castello vicino Capranica, a Bassano di Sutri. Alla festa troviamo nobili annoiati, decadenti, dissoluti. Per arrivare all’alba, viene organizzata una caccia ai fantasmi, con tanto di seduta spiritica, nella casa adiacente alla villa chiusa da molto tempo. Marcello ritrova, per poi perderla così come è inaspettatamente apparsa, Maddalena. I dieci minuti successivi il film li consuma in due scene. Nella prima (la undicesima, quattro minuti) Emma e Marcello hanno un furibondo alterco in auto. La donna viene prima picchiata e in seguito abbandonata, di notte, in una strada desolata. Appena ha fatto giorno, Marcello ritorna e fa salire Emma sull’automobile. Con una dissolvenza ritroviamo i due a letto. Squilla il telefono, Marcello assonnato risponde, e il suo volto si contrae per la notizia ricevuta. Siamo alla dodicesima scena (sei minuti). Marcello arriva nella casa di Steiner: l’uomo inspiegabilmente ha ucciso i due figli e poi si è tolto la vita. Rivediamo la casa, piena di luce; Steiner è ancora seduto sulla poltrona, come qualche giorno prima, ma si è sparato un colpo di pistola alla testa. La moglie di Steiner è andata al cinema, e sta per rincasare. Marcello si offre di accompagnare il commissario di polizia. In strada i fotografi e i cineoperatori sono numerosi. Arriva la moglie di Steiner, e viene assediata: si scattano foto a ripetizione. La donna sulle prime pensa di essere stata scambiata per un’attrice, e sorride. Poi vede Marcello: capisce che se tutti quei fotografi sono lì, è accaduta certamente una disgrazia. La donna viene fatta salire sulla macchina della polizia e Marcello ha lo sguardo perso nel vuoto.
Il film si conclude con la tredicesima scena, piuttosto lunga (venti minuti) ed importante. È una chiusura terribile, desolata, squallida e violentissima: la pura «onnipotenza orgiastica» di cui parlava Kundera. Fellini articola il racconto in cinque blocchi:
1 – un corteo di macchine, sorpassandosi, con i fanali accesi nella notte corre sulla strada rumorosamente
2 – le auto si fermano davanti ad una villa di Fregene, località balneare a poca distanza da Roma, raggiungibile percorrendo la via Aurelia: non avendo le chiavi del cancello una vettura sfonda la porta di ingresso, e visto che nella casa non c’è nessuno, Marcello con un sasso rompe la vetrata
3 – la serata comincia con due uomini vestiti da donna che ballan; prosegue con una crudele e gratuita presa in giro di Marcello, accusato di aver definitivamente rinunciato alla letteratura, per trasformarsi da scrittori in agente pubblicitario; e va avanti prima con lo spogliarello di Nadia (Nadia Gray) sulle note Patricia, poi si trascina stancamente con un tentativo di orgia organizzata da Marcello, per finire con Marcello impegnato a umiliare e coprire di piume una attricetta in cerca di fortuna ubriaca
4 – terminata la festa, alle primi luci dell’alba, i partecipanti si ritrovano nella vicina pineta, e da lì raggiungono la spiaggia: alcuni pescatori stanno tirando le reti con dentro uno strano mostro marino
5 – anche Marcello, uscito per ultimo dalla villa, si affretta a vedere il mostro, ma è richiamato da Paola, la ragazzina incontrata sulla spiaggia qualche giorno prima: il rumore del mare disturba il loro dialogo a distanza e riescono solo scambiarsi alcuni gesti e un saluto.
Certamente La dolce vita oltrepassa la visione unitaria del mondo tipica dei film classici; ma la nuova visione proposta non è la negazione di questa unitarietà, né possiamo considerarla un prototipo del superamento delle «grandi narrazioni», che determinano la fine della modernità, come sostiene Cfr., Jean-François Lyotard[19]. In La dolce vita si delinea una lettura del mondo dettata dall’ambiguità, poiché è il mondo ad essere diventato sempre più complesso, difficile da capire e da abitare, con l’individuo schiacciato dai richiami della società secolarizzata. Per questa ragione il film di Federico Fellini non può essere considerato l’esaltazione di un passaggio epocale: invece è il ritratto nitido, in forma epica, delle debolezze dell’uomo davanti ad avvenimenti che non può e non riesce a dominare, avendo smarrito la propria identità. Come ricordato La dolce vita si apre con un prologo e si chiude con un epilogo. In queste due brevi sequenze è racchiusa la nostalgia per il sacro e la curiosità per l’affermarsi di un nuovo stile di vita dettato dalla moda, dallo spettacolo, dai comportamenti imposti dall’evoluzione della società capitalista. Nel prologo la statua di Cristo è sospesa sui cieli di Roma, trasportata da un elicottero. Nell’epilogo assistiamo invece, all’alba, in riva alla spiaggia, alla pesca di un mostro marino. Quel Cristo sospeso incarna – naturalmente in forma simbolica – l’epoca dell’eclissi del sacro, dell’allontanamento di Dio dagli uomini. Nell’epilogo Marcello, dopo aver trascorso una squallida nottata, inaspettatamente è costretto ad osservare l’orribile pesce dall’occhio umano, trascinato sulla spiaggia dalle reti dei pescatori. Seduto sulla sabbia, assonnato e turbato dall’occhio dello strano animale, si sente a disagio. Marcello ha bisogno di fuggire dallo sguardo inquisitore, ed ecco arrivare, misteriosamente, uno sguardo opposto, non severo ma dolce, non colpevolizzante ma rassicurante. Sulla spiaggia appare Paola. Scambiando qualche parola con lei in occasione del primo loro incontro al ristorante, Marcello le aveva detto: «sembri un angioletto nei quadri delle chiese umbre». Marcello non riesce a sentire cosa gli dice Paola; ora è in ginocchio, il suo sguardo è triste. Quello di Paola è invece splendente. Marcello torna ad unirsi all’infelice e disincantata compagnia con la quale sta vivendo la sua «dolce vita».
Questo finale non era previsto nella sceneggiatura originale[20]. Brunello Rondi ha colto il senso morale della conclusione: «Il film finisce sul primo piano della bambina che guarda, ancora una volta, con fiducia, con simpatia, con speranza quasi, Marcello tornato in mezzo ai mostri. Si tratta, con ogni evidenza, d’una figura di riscatto […] tutto sembra significare una cifrata allusione di rinascita, di amore, che per il protagonista arriva troppo tardi. È, allora, proprio questa rinuncia ad ogni riscatto finale del personaggio, o del mondo umano e sociale realizzato sin qui in allegoria, che toglie ogni possibile conciliazione di comodo allo spettatore e gli impedisce di scaricare, anche in minima parte, la tensione raggiunta. La dolce vita rimane, così, senza appiglio di evasione o di distensione, senza possibilità di sistemazione o di archiviamento, uno dei più formidabili blocchi di visionarietà angosciosa, d’inconciliabilità di crisi, creato dal cinema moderno»[21].. In realtà la scena finale di La dolce vita è costruita per mostrare la vera identità di Marcello. La morte di Steiner (avvenuta nella scena precedente) ha definitivamente tolto ogni possibilità di redenzione a Marcello. Egli vede ancora la salvezza (la vede riflessa nel sorriso e nella purezza di Paola), ma non può afferrarla. La possibilità della salvezza si presenta ancora al protagonista; la sente a portata di mano, ma non è capace di rinunciare all’appagamento dei desideri, per i quali ha perso tutto: amore, affetti, vincoli familiari, amicizie, vocazione di scrittore, dignità di se stesso. Per Marcello la «teofania» (apparizione o manifestazione sensibile della divinità) è qualcosa di concreto e percettibile, di cui avverte nostalgia, ma non sperimentabile, poiché il richiamo delle sirene della «città secolare» è imprescindibile.
[1]Gian Piero Brunetta, Guida alla storia del cinema italiano. 1905-2003, Einaudi, Torino 2003, p. 191
[2]Gian Piero Brunetta, Il cinema italiano contemporaneo. Da “La dolce vita” a “Centochiodi”, Laterza, Roma-Bari 2007, p. 315.
[3]Tullio Kezich, Noi che abbiamo fatto La dolce vita, Sellerio, Palermo 2009, p. 11.
[4]Ibid., p. 15.
[5]Di questa tendenza interpretativa uno degli studi più significativi è dovuto a Norman Denzin, The Cinematic Society. The Voyeur’s Gaze, Sage, Londra 1995, p. 15.
[6]Antonio Tabucchi, La mia storia comincia dalla Dolce vita, intervista di Ranieri Polese, in «Corriere delle Sera», 7 agosto 1994.
[7]Pietro Scoppola, La repubblica dei partiti. Profilo storico della democrazia in Italia (1945-1990), il Mulino, Bologna 1991, p. 251.
[8]Cfr., Hank Kaufman – Gene Lerner, Hollywood sul Tevere, Sperling & Kupfer, Milano 1982.
[9]Vito Zagarrio, Fellini dal moderno al postmoderno, in Giorgio De Vincenti (a cura di), Storia del cinema italiano, vol. X, Marsilio, Venezia 200 , p. 82.
[10]Peter Bondanella inserisce La strada e Le notti di Cabiria nella «trilogia della grazia e della speranza», composta a suo avviso anche da La dolce vita, che in realtà con gli altri due film ha solo esili legami e più discontinuità che punti di contatto: Peter Bondanella, The Films of Federico Fellini, Cambridge University Press, Cambridge 2002, p. 66.
[11]Sui «Cahiers du cinéma» gli allora critici Eric Rohmer e Jaques Rivette recensirono le opere rosselliniane, tra il 1953 e il 1955, ritenendole una svolta per il nuovo cinema.
[12]Ne sono esempio le analisi sfavorevoli dei film di Rossellini e di Fellini dello studioso marxista Guido Aristarco, apparse sulla rivista da lui diretta «Cinema Nuovo».
[13]René Predal, Cinema: cent’anni di storia, op. cit., p. 233..
[14]Tullio Kezich, Noi che abbiamo fatto La dolce vita, Sellerio, Palermo 2009, p. 24.
[15]Cfr., Jacques Aumont, Moderne? Comment le cinéma est devenu le plus singulier des arts, Cahiers du cinéma, Parigi 2007, p. 46.
[16]Cfr., Sabino Acquaviva pubblicava l’articolo Neopaganesimo e società industriale, in «Il Mulino», n. 97, 1959, ampliato nel saggio L’eclissi del sacro nella civiltà industriale, Edizioni di Comunità, Milano 1961.
[17]Tullio Kezich, Noi che abbiamo fatto La dolce vita, op. cit., p. 25.
[18]Ibid.,p. 163
[19]Cfr., Jean-François Lyotard, La condition postmoderne, Éditions du Minuit, Parigi 1979.
[20]Cfr., Tullio Kezich (a cura di), La dolce vita di Federico Felllini, Cappelli, Bologna 1960, pp. 242-243
[21]Brunello Rondi, Il cinema di Fellini, Edizioni di Bianco e Nero, Roma 1965, p. 107
Autore: Claudio Siniscalchi
Details of Movie
| Titolo Originale | La dolce vita |
|---|---|
| Paese | Italia |
| Etichetta | Non classificato |







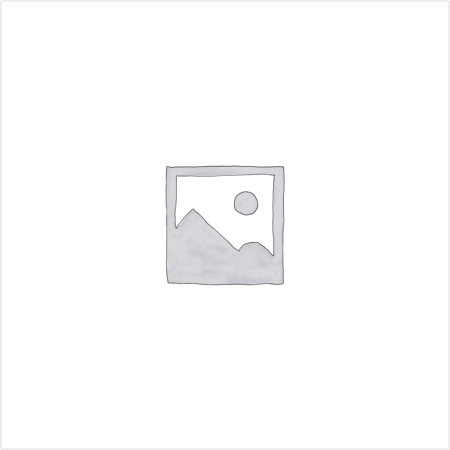

There are no reviews yet.